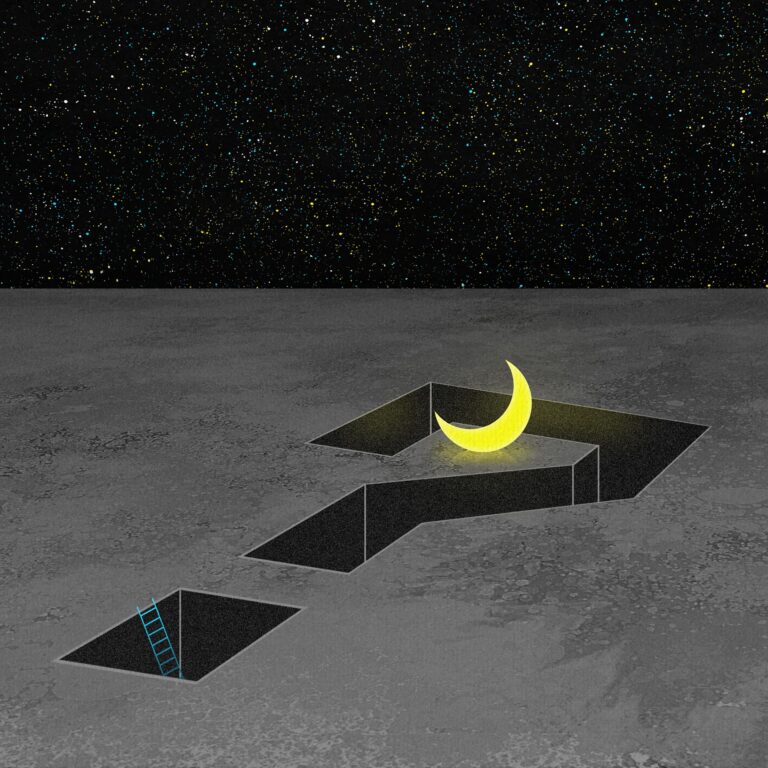Nella dimora di Zeus vi sono due grandi orci che ci dispensano l’uno i mali, l’altro i beni: li mescola il dio delle folgori, e colui a cui ne fa dono riceve ora un male ora un bene; e chi riceve dolori diventa un miserabile, una fame cattiva lo spinge per tutta la terra, e lui va errando, disprezzato dagli dei, odiato dagli uomini.
Iliade XXIV, 527-533
Fra i numerosi tratti che caratterizzano il profilo del mendicante nella letteratura greca antica[1], uno dei più ricorrenti e significativi è costituito dalla fame smodata e insaziabile. Si tratta di quella fame cattiva evocata da Achille nel celebre discorso a Priamo del XXIV libro dell’Iliade riportato sopra, che accompagna costantemente l’uomo miserabile cui Zeus ha destinato una vita di dolori.
Emblema potente di questo appetito irrefrenabile è, nella percezione greca, la gastèr, il ventre mai soddisfatto dell’accattone: esso costituisce un vero e proprio suggello iconografico della marginalità e – dall’età arcaica fino alle testimonianze più tarde – continua a rappresentare il segno inequivocabile di una minorità socio-economica che non di rado si traduce in atteggiamenti e comportamenti contrari alla morale pubblica e privata condivisa dalla comunità.
Attorno all’immagine del ventre si addensa, già nei poemi omerici, una serie di dicotomie tra istanze sociali e politiche antitetiche e inconciliabili[2]. La prima, basilare opposizione è quella tra l’esercizio di un’attività e l’assenza di occupazione o, in altri termini, tra il lavoro salariato dei teti[3] – pur umile e socialmente degradato – e il non-lavoro dei mendicanti; un discrimine che il testo omerico tematizza con insistenza, nell’Odissea di solito per bocca dei pretendenti di Penelope o delle figure ad essi collegate; quando il servo Melanzio, mentre conduce le capre al palazzo di Itaca per un banchetto, si imbatte nel porcaro Eumeo e in Odisseo travestito da mendicante, li apostrofa con queste parole:
Ecco un villano che guida un altro villano: dio accoppia sempre il simile al simile. Dove porti questo morto di fame, disgraziato porcaro, questo mendicante, divoratore di avanzi? Si consumerà le spalle, costui, appoggiandosi a molti stipiti per chiedere tozzi di pane, non certo spade né lebeti. Se a me tu lo dessi, a fare il guardiano di stalla, a pulire il letame, a portare foraggio ai capretti, si farebbe le cosce robuste, bevendo il siero del latte. Ma poiché ha imparato soltanto a fare del male, non vorrà lavorare di certo: preferisce nutrire il suo ventre insaziabile mendicando in mezzo alla gente. [Odissea XVII, 217-229]
L’accusa di rifiutare il lavoro a vantaggio dell’ozio e del ventre insaziabile è preceduta, nell’invettiva di Melanzio, da una notazione lapidaria ma assai significativa: solo i bocconi di pane interessano al mendicante divoratore di avanzi, non le spade e neppure i lebeti, due elementi che evocano con ogni evidenza l’universo epico del valore in battaglia e del trionfo militare; l’accattone – in greco ptochos – rappresenta cioè, in questo caso, l’emblema di una morale a rovescio, un’ “etica del ventre” che si contrappone all’etica eroica propria delle aristocrazie greche arcaiche, che si sostanzia di status symbols legati alla sfera della guerra e che trova nell’Iliade la sua più compiuta espressione.
Ancora sulla dicotomia lavoro vs. ozio ritorna uno dei pretendenti, Eurimaco, che attacca Odisseo mendicante per la sua inadeguatezza alla fatica fisica:
“Ma poiché hai appreso solo azioni dappoco, non vorrai lavorare, ma mendicare piuttosto fra il popolo per nutrire il tuo ventre insaziabile.” [Odissea XVIII, 362-364]
La risposta dell’eroe non si fa attendere:
“Eurimaco, se dovessimo fare a gara tra noi, a primavera, quando i giorni sono più lunghi, in un prato con tanta erba, e io avessi una falce ricurva e tu pure una ne avessi per misurarci al lavoro fino a sera, senza mangiare; o se dovessimo spingere buoi di colore fulvo, i più forti, i più grandi, sazi di fieno, pari di forza e di età, pieni di inesausto vigore, in un campo di quattro misure dove la terra cede all’aratro, allora tu mi vedresti tagliare solchi senza fermarmi. E se infine una guerra scatenasse il figlio di Crono, oggi stesso, e io avessi uno scudo e due lance e un elmo di solido bronzo calzato alle tempie, mi vedresti allora in prima fila e non mi parleresti così biasimandomi per il mio ventre.” [Odissea XVIII, 366-380]
Anche Telemaco subisce lo scherno dei pretendenti per la qualità scadente dei suoi ospiti, inutili fardelli incapaci di qualsiasi attività che esuli dall’assunzione smodata di cibo e bevande:
Telemaco, nessuno è più sfortunato di te con gli ospiti; questo qui è un mendicante ramingo, affamato di cibo, di vino, inetto alla fatica e al lavoro. Inutile peso alla terra. [Odissea XX, 376-380]
L’inabilità al lavoro e alla fatica e il bisogno smodato di cibo suonano come il più offensivo degli insulti rivolti dai pretendenti a Odisseo mendicante[4]; ma il ventre insaziabile segnala nel poema anche un’altra coppia oppositiva, tra una vita sociale condotta entro i confini (fisici e politici) di una comunità organizzata e lo stigma dell’esistenza raminga e itinerante del mendicante; una condizione che si giustifica, nella concezione omerica, proprio in ragione delle necessità insopprimibili della fame e del ventre:
Niente è più amaro per gli uomini di una vita raminga, e tuttavia, per il maledetto ventre, pene crudeli sopportano coloro cui tocca andare vagando fra angosce e dolori. [Odissea XV, 343-345]
il ventre affamato, che costringe il mendicante ad una itineranza forzata, ha poi, nell’opinione comune, anche il potere di ottundere le facoltà di giudizio e indurre ad azioni sconsiderate: su questa idea condivisa fa leva Odisseo nel suo discorso ai pretendenti prima del duello con l’altro mendicante di Itaca, Iro, per dare credibilità alla sua messinscena:
Miei signori, non è possibile che un giovane lotti con un vecchio oppresso dalla sventura, ma è il ventre maligno che mi costringe a subire. [Odissea XVIII, 52-54]
La gastèr maligna non conosce ragioni e spinge ad azioni governate dal puro istinto. In questo senso si potrebbe affermare che proprio il ventre costituisca a tutti gli effetti la causa prima della condizione minoritaria del mendicante e, in ultima analisi, della mendicità tout court. Gli aggettivi che nell’Odissea accompagnano il termine gastèr hanno tutti una connotazione negativa e – non a caso – sono quelli che più frequentemente ricorrono nella caratterizzazione omerica del mendicante: insaziabile[5], funesta[6], misera[7], maligna[8], incontrollata, vorace[9].
Preda del richiamo del ventre, il mendicante occupa il gradino più basso della società omerica: la sua condizione è peggiore di quella degli schiavi, che – seppure a prezzo della libertà – non subiscono le conseguenze della cattiva fame. Di più: il dominio incontrollato del ventre colloca lo ptochòs in uno spazio culturale contiguo più alla bestialità che alla civiltà[10]; il bisogno di cibo, sembra suggerire il testo dell’Odissea, è una forza più potente di ogni etica eroica, poiché è in grado di trasformare un uomo, definito dalla sua ragione, dalla sua appartenenza sociale e dalle sue norme morali, in un sub-uomo, guidato esclusivamente dalle necessità primarie della sopravvivenza.
Il difficile rapporto dei mendicanti con l’universo alimentare attraversa tutta la letteratura greca antica[11].
Ancora attorno ai bisogni del ventre si interroga alla fine del VI sec. a.C. Teognide, che propone l’immagine di un uomo, un tempo benestante, costretto ora a mendicare dopo aver dilapidato le proprie sostanze per soddisfare il ventre[12]. Un tema, questo, che si ritrova ricorrentemente anche nell’opera superstite di Ipponatte e che diverrà in seguito un motivo caro alla commedia.
Proprio l’idea della mendicità come conseguenza diretta dello sperpero sconsiderato dei beni è ripresa poi da Platone in un discusso passaggio della Repubblica in cui Socrate, illustrando al suo interlocutore i difetti della costituzione oligarchica, paragona i mendicanti ai fuchi senza pungiglione[13]: un’immagine già presente nelle opere di Esiodo, dove i fuchi sono caratterizzati principalmente per la loro gastèr[14] e per l’attitudine all’ozio, contrapposta all’operosità delle api[15]. Di nuovo, dunque, un richiamo al non-lavoro come causa della fame smodata[16].
La pancia del mendicante diventa, nel corso dei secoli, un’icona paradigmatica per indicare la aplestìa, l’insaziabilità; abbiamo notizie dalle raccolte paremiografiche di un detto, attribuito originariamente a Callimaco e assurto poi a proverbio popolare[17], che così recita:
La bisaccia del mendicante non si riempie mai.
Il binomio povertà-fame costituisce un tema ricorrente anche nel teatro comico; solo a titolo esemplificativo, basterà qui citare il Pluto di Aristofane, dove Penìa, la personificazione della povertà, afferma di rendere gli uomini migliori poiché con la ricchezza sono grassi di ventre e di cosce, mentre con lei sono sottili come vespe e capaci di fronteggiare i nemici[18].
Le pratiche alimentari rappresentano com’è noto uno dei tratti più emblematici per la definizione e la distinzione sociale all’interno di un sistema culturale dato[19].
In questo senso, ciò che emerge dal dato letterario è la persistente sottolineatura della deprivazione alimentare degli πτωχοί: una condizione che rappresenta per i Greci, lo abbiamo detto, il discrimine più forte tra umanità e bestialità e determina la prevalenza delle necessità e degli istinti del ventre su ogni altra forma di controllo esercitata dalla ragione, dall’etica condivisa o dalla consuetudine.
La mancanza di cibo – così come il suo risvolto, vale a dire l’ingordigia smodata e l’insaziabilità quando se ne ha a disposizione – costituisce dunque, nell’immaginario greco antico, la ragione principale della diffidenza diffusa nei confronti dei mendicanti.
Avanzo inerte e improduttivo di una società efficiente e laboriosa, lo ptochòs è egli stesso un residuo, e di residui è fatta la sua esistenza: occupa gli spazi residuali e periferici della vita civica, si veste di stracci, scarti e brandelli di ciò che un tempo era stato un indumento, soprattutto si nutre dei resti e dei residui racimolati dalle tavole altrui. I beni che riceve in elemosina – per lo più cibo – sono sempre effimeri, temporanei, non tesaurizzabili: destinati cioè a durare per il breve tempo necessario a consumarli. Non c’è prospettiva né futuro, nella vita del mendicante: l’assenza di lavoro e la mancata accumulazione lo collocano in un presente immutabile e incerto, in cui la sopravvivenza è subordinata alla incostante compassione degli avventori.
Questo speciale posizionamento del mendicante nel gioco dei rapporti economici influenza inevitabilmente in maniera determinante la sua collocazione sul versante delle relazioni sociali e politiche. Tanto nel mondo dell’oikos arcaico evocato dai poemi omerici quanto nella realtà più dinamica della polis, il mendicante rimane escluso dalle normali interazioni sociali tra i membri della comunità, poiché tali interazioni si fondano stabilmente su vincoli di reciprocità: una condizione, questa, che uno ptochòs non può in alcun modo soddisfare, poiché la sua fame smodata e la sua indigenza permanente lo rendono incapace di qualsiasi reciprocità nel dono o nello scambio, impedendogli di intessere relazioni che non siano strutturalmente asimmetriche.
Trovandosi quotidianamente nella più estrema delle necessità – sopravvivere – il mendicante non stabilisce legami duraturi, e viene perciò descritto in tutte le fasi della storia letteraria greca come un opportunista, le cui azioni sono guidate unicamente dal soddisfacimento dei bisogni momentanei e il cui esclusivo interesse consiste di solito nel riempire il proprio ventre insaziabile. Questa tendenza individualistica, che nel mondo dell’epos viene percepita nei termini di un’etica anti-eroica, nel contesto della polis si traduce in una attitudine anti-politica, che relega il mendicante ai margini della vita pubblica.
Alla luce di queste considerazioni, come si spiega allora l’imperativo morale all’accoglienza e all’ospitalità nei confronti dei mendicanti che attraversa – sia pure con diversa intensità e diverse modalità – tutta la letteratura greca antica?
Per rispondere a questa domanda, occorre ritornare al testo omerico dell’Odissea: tutti gli stranieri e i mendicanti vengono da Zeus – affermano in momenti diversi la principessa di Scheria Nausicaa e il porcaro di Itaca Eumeo[20]. Stranieri e mendicanti rappresentano cioè, con la loro stessa esistenza, il potere assoluto e imperscrutabile della tyche, la sorte che governa i destini dei mortali e che senza preavviso può far cadere un uomo dalle vette della regalità o del benessere economico alla più bassa e degradata delle condizioni. È per questo che i mendicanti sono sacri a Zeus: perché esprimono in tutta la sua tragica labilità, il carattere effimero della condizione umana. L’obbligo di accogliere nutrire il mendicante, tematizzato chiaramente nell’epica omerica e ancora sentito alle soglie dell’età ellenistica, è dunque legato strettamente al timore e al rispetto di una imperscrutabile volontà divina; e tuttavia, nell’atteggiamento verso i mendicanti è presente e operante anche un altro stimolo, di natura genuinamente etica: si percepisce cioè, nei testi in nostro possesso, un principio di solidarietà che riposa sulla comune appartenenza al genere umano, costitutivamente soggetto ai rivolgimenti improvvisi di fortuna e alle insidie della sorte.
Anche dal punto di vista etimologico, nella percezione greca, il termine per definire un mendicante, ptochòs, è connesso al verbo pìpto, cadere[21]. Dal punto di vista della ‘coscienza linguistica’ antica, identificare il mendicante con un ‘caduto’ significa riconoscerlo non per la posizione che occupa o per l’attività che svolge, bensì per la sua storia personale, per la sua irripetibile vicenda individuale e per gli eventi che lo hanno portato a ‘cadere’. Ma significa anche riconoscersi in lui, e ammettere che la più bassa fra le condizioni economiche e il più degradato fra i ruoli sociali rappresentino un’eventualità in cui ciascuno può incorrere, indipendentemente dal rango o dalla posizione che egli occupa nel momento presente.
È proprio in questo aspetto che risiede, io credo, la più vistosa differenza fra la rappresentazione greca del mendicare e la percezione contemporanea dei fenomeni di accattonaggio.
Tramontato nel corso dei secoli l’obbligo di natura religiosa, e tramontato per molti versi anche l’afflato pietistico di matrice cristiana che animava l’accoglienza e il sostegno ai mendicanti in età medievale e moderna, oggi sembra affievolirsi anche quel principio di solidarietà umana, tanto verso la ‘mendicità interna’ quanto verso la povertà radicale che arriva dall’esterno, nelle forme di un flusso migratorio proveniente da quei paesi dell’Africa e del Medio Oriente ormai fiaccati da decenni di guerre, instabilità indotta e sfruttamento neo-colonialista.
Alla fine del XX secolo, l’ostilità e il disprezzo dei cittadini ‘normali’ nei confronti dei mendicanti – pure esecrabile – poggiava sull’idea illusoria che fosse compito esclusivo dello Stato occuparsi dei soggetti sociali più deboli, grazie alle risorse economiche incamerate attraverso la contribuzione fiscale: pagando le tasse, si riteneva di aver assolto ogni obbligo nei confronti della collettività, e di avere dunque il ‘diritto’ di restare indifferenti rispetto alle iniquità sociali e alle sofferenze altrui: un «diritto negativo di cittadinanza»[22] che ha contribuito all’erosione progressiva del senso di comunità e ha accentuato lo iato tra ‘integrati’ e ‘outsiders’.
Gli ultimi quindici anni – complice la crisi globale che ha investito le economie occidentali a partire dal 2008 e il conseguente impoverimento generalizzato delle classi medie – hanno visto una ulteriore degenerazione di questi processi: da un lato permane un certo malcelato fastidio nei confronti della mendicità urbana, che spesso degenera in vera e propria violenza; dall’altro, l’incontro ormai quotidiano con la povertà assoluta dei profughi africani e medio-orientali, che giungono sulle coste dell’Europa mediterranea dopo aver perso tutto – la propria casa, i propri cari e spesso anche la salute fisica e l’integrità psicologica – si risolve oggi, per buona parte della popolazione, in un sentimento livoroso di xenofobia, quando non di esplicito razzismo. Mentre le istituzioni – pur con la lentezza burocratica che le caratterizza – provano a mettere in atto quelle procedure di accoglienza e solidarietà che, dopo la II Guerra Mondiale, hanno sostanziato il diritto internazionale, nel senso comune si va facendo strada un nuovo mito dell’autoctonia, basato su un astratto e malinteso principio di identità, che viene alternativamente declinato in senso locale, nazionale o più genericamente ‘occidentale’. Ben poco ha a che fare, tutto questo, con la preservazione e la difesa di una comunità: piuttosto, risponde ad un impulso meschinamente individualistico, imperniato sull’idea che l’appartenenza anagrafica o giuridica ad una compagine territoriale costituisca di per sé un ‘merito’ di cittadinanza e garantisca in forma prioritaria o esclusiva l’accesso ai diritti basilari di esistenza e di sopravvivenza.
Quando si è perduto il senso della tyche, vale a dire la consapevolezza che solo per un caso fortuito siamo nati ‘dalla parte giusta’ del mare, allora diventa difficile riconoscere il mendicante o lo straniero come portatori di una storia fatta di cadute e risalite; e ancora più difficile è riconoscersi in colui che non ha niente, sulla base di una comune appartenenza.
NOTE
[1] In generale sulla figura del mendicante nella Grecia antica mi permetto di rimandare a Giammellaro 2019, con bibliografia precedente.
[2] Svenbro 1984, pp. 63-64.
[3] Finley 2012II, pp. 65-67.
[4] Si tratta, occorre sottolinearlo, di un’offesa che, nel contesto dei libri finali dell’Odissea, assume valenze molteplici: se da un lato – nella finzione del travestimento – il mendicante è impossibilitato a svolgere un’attività lavorativa, ed è dunque, per certi versi, una vittima incolpevole del suo ventre, dall’altro – nella realtà della situazione narrativa – Odisseo rappresenta tra gli eroi greci di gran lunga il più versatile per “attitudine al lavoro”: è un abile combattente, un eccellente stratega e un esperto navigatore, conosce le tecniche dell’agricoltura ed è in grado, all’occorrenza, di costruire un’imbarcazione, di lavorare il legno, di edificare una casa. L’accusa di inettitudine a lui rivolta appare perciò, agli occhi dell’uditorio, addirittura ironica.
[5] Odissea XVII, 228; XVIII, 364. ἄναλτος è usato anche per definire lo πτωχὸς πανδήμιος Iro: Od. XVIII, 114.
[6] Odissea XV, 344; XVII, 287.
[7] Odissea XVIII, 473.
[8] Odissea XVIII, 54.
[9] Odissea XVIII, 2.
[10] Cfr. Bertelli 1989, p. 105.
[11] Sotto questa specie, il mendicante condivide molti dei tratti che caratterizzano proverbialmente la figura del parassita: cfr. Guastella 1988 e Avezzù 1989, passim.
[12] Teognide I, 920-924.
[13] Platone, Repubblica VIII, 552 a-d.
[14] Esiodo, Teogonia 544.
[15] Esiodo, Le opere e I giorni 303-306.
[16] Cfr. Vernant 1982, pp. 70-76.
[17] Nella raccolta di Zenobio (5, 66), si riporta anche una spiegazione: “La bisaccia del mendicante non si riempie mai. Questo è stato detto da Callimaco a proposito dei mendicanti insaziabili”. Cfr. anche Diogenian. 7, 51; Mich. Apost. 15, 8; Suda s.v. Πήρα (1534).
[18] Aristofane Pluto 557-561.
[19] Su questi temi si veda la raccolta di saggi curata da Longo – Scarpi 1989; segnalo qui in particolare Nenci 1989, Bertelli 1989 e Avezzù 1989.
[20] Odissea VI, 207-208 = XIV, 57-58.
[21] Si tratta con ogni probabilità di una paretimologia: i linguisti moderni hanno individuato infatti l’etimologia del termine nel verbo ptosso, che significa acquattarsi, rannicchiarsi o nascondersi (Chantraine 1999II, pp. 948-949; Beekes 2010, pp. 1248-1249 e 1253); tuttavia, a fronte dell’imprecisione linguistica, le notazioni dei grammatici ellenistici ci aprono una finestra diretta sulla percezione antica della parola, offrendoci in questo modo anche una diversa chiave interpretativa.
[22] Così lo ha definito il sociologo britannico Bill Jordan: Jordan 1999, pp. 54-56.
BIBLIOGRAFIA
E. Avezzù, Il ventre del parassita: identità, spazio e tempo discontinuo, in Longo – Scarpi 1989, pp. 235-240
R. Beekes, Etymological Dictionary of Greek, Brill, Leiden – Boston 2010
L. Bertelli, I sogni della fame dal mito all’utopia gastronomica, in Longo – Scarpi 1989, pp. 103-114
P. Chantraine, Dictionnaire Étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Nouvelle édition avec supplément, Klincksieck, Paris 1999II [1968]
M. I. Finley, Il mondo di Odisseo, PGreco, Milano 2012 (New York 1956)
P. Giammellaro, Il mendicante nella Grecia antica. Teoria e modelli, Quaderni di Studi e Materiali di Storia delle Religioni 23, Morcelliana, Brescia 2019
G. Guastella, Topi e parassiti, la tradizione di mangiare il cibo altrui, in G. Guastella, La contaminazione e il parassita. Due studi su teatro e cultura romana, Giardini Editore, Pisa 1988, pp. 81-111
B. Jordan, Begging: the Global Context and International Comparisons, in H. Dean (ed.), Begging Questions. Street-level Economic Activity and Social Policy Failure, Bristol 1999, pp. 43-62
O. Longo – P. Scarpi (edd.), Homo Edens. Regimi, miti e pratiche dell’alimentazione nella civiltà del Mediterraneo, Verona 1989
G. Nenci, Pratiche alimentari e forme di definizione e distinzione sociale nella Grecia antica, in Longo – Scarpi 1989, pp. 25-30
J. Svenbro, La parola e il marmo. Alle origini della poetica greca, Torino 1984 (Lund 1976)
J. P. Vernant, Alla tavola degli uomini: mito di fondazione del sacrificio in Esiodo, in M. Detienne – J. P. Vernant (edd.), La cucina del sacrificio in terra greca, Torino 1982 (Paris 1979), pp. 27-89