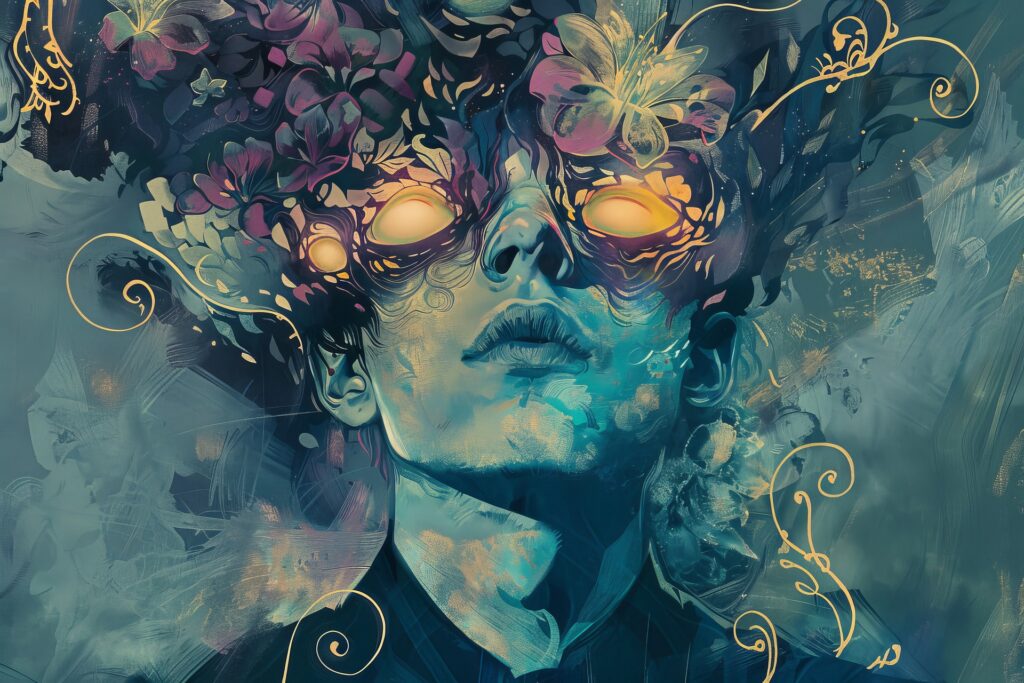“Solo chi sogna può trasformare”, scriveva Danilo Dolci.
Questa frase, divenuta celebre, è più di una formula ispirazionale: è la sintesi di un pensiero pedagogico, politico ed esistenziale che ha attraversato tutta la sua opera. In un contesto segnato da povertà, analfabetismo e violenza sistemica – quello della Sicilia occidentale del secondo dopoguerra – Dolci ha elaborato una pratica educativa e sociale in cui sogno e bisogno non sono in opposizione, ma in dialogo. Il sogno rappresenta l’apertura verso un possibile futuro diverso, mentre il bisogno, riconosciuto e condiviso, costituisce il punto di partenza per l’azione collettiva. Nel mezzo, vi è la paura, intesa come condizione umana e sociale da attraversare, non da ignorare né da reprimere.
Questo articolo vuole esplorare come sogno e bisogno si articolino nel pensiero e nell’azione di Danilo Dolci come strumenti di contrasto alla paura, partendo da alcune esperienze emblematiche della sua pedagogia militante e della sua pratica sociale e politica.
Danilo Dolci ha saputo coniugare come pochi il sogno e il bisogno, due parole che nella sua opera diventano strumenti di lotta e trasformazione. Nella Sicilia degli anni Cinquanta e Sessanta, segnata da miseria materiale, povertà educativa e soprattutto controllo assoluto della Mafia collusa alla politica e ad apparati dello Stato, Dolci non si è limitato a immaginare un mondo diverso: ha dato voce e metodo a un desiderio collettivo, partendo dai bisogni primari e arrivando alla liberazione profonda dell’essere umano.
Per capire a pieno l’opera e il pensiero di Danio Dolci è bene riportare una sua breve biografia. Danilo Dolci (Sesana, 28 giugno 1924 – Partinico, 30 dicembre 1997) è stato un attivista sociale, educatore, poeta e sociologo italiano, noto per il suo impegno nonviolento in Sicilia e per essere stato definito il “Gandhi italiano”. Nato in una zona di confine, da madre slovena e padre italiano, si formò tra Nord e Centro Italia, avvicinandosi negli anni alla comunità di Nomadelfia (Grosseto) e agli ideali cristiani del Vangelo praticato. Dopo esperienze a Milano e Roma, si trasferì nel 1952 a Trappeto, un villaggio della Sicilia occidentale, dove avviò la sua azione sociale accanto ai più poveri, con metodi di disobbedienza civile nonviolenta. Tra le sue iniziative più note vi è lo “sciopero alla rovescia”, con cui i disoccupati sistemavano strade pubbliche abbandonate, azione che gli valse arresti ma anche solidarietà da parte di intellettuali come Calamandrei, Capitini, Sciascia, Huxley, Moravia e molti altri. Lottò contro la mafia, l’analfabetismo e lo sfruttamento, fondando il Centro studi e iniziative per la piena occupazione, la prima radio libera italiana e promuovendo la costruzione della diga sul fiume Jato per dare lavoro e acqua alla popolazione. Il suo metodo educativo, detto maieutico reciproco, si fonda sul dialogo e sull’ascolto attivo come strumenti di crescita collettiva e personale. E’ stato autore di saggi e inchieste sociali, tra cui Banditi a Partinico, Spreco, Chi gioca solo e Inchiesta a Palermo, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Lenin per la pace (1958) e il Premio Gandhi.
LA PAURA COME DISPOSITIVO DI CONTROLLO
Nel Mezzogiorno italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, la paura è una forma diffusa di dominio. Si manifesta nella rassegnazione alla miseria, nella soggezione alla mafia, nel silenzio imposto dalle strutture sociali e politiche. Dolci giunge a Trappeto nel 1952 e poi a Partinico, dove questa paura è palpabile: paura di parlare, di denunciare, di immaginare un’alternativa.
«Ho imparato a temere il silenzio della gente. Non quello che riposa, ma quello che cova la sconfitta».
(Danilo Dolci, Ciò che ho imparato e altri scritti, Mesogea 2007)
L’esperienza di Dolci parte proprio dall’ascolto di questo silenzio. Non si propone come salvatore esterno, ma come partecipe di un processo di consapevolezza che passa per la parola, per il racconto, per la condivisione del bisogno. Ovviamente la sua azione infastidisce la Mafia e la Politica e gli avvertimenti con l’invito a “visite come queste devono finire” alludendo alle sue denunce sulla povertà materiale, con l’assenza totali di servizi, quali le fognature, l’acqua corrente, la corrente elettrica. In contesti segnati da violenza, sopraffazione e silenzio forzato – come quello del Belìce e del Trapanese – la paura è una forma diffusa di controllo. Paura della fame, della denuncia, della mafia, dell’umiliazione. È un dispositivo di potere. Danilo Dolci ne era consapevole, e per questo ha deciso di mettersi in ascolto. Con i suoi “scioperi alla rovescia” e le inchieste poetiche, ha fatto della paura un punto di partenza, non di paralisi.
“Solo chi sogna può trasformare,” scriveva. Ma per sognare, serve prima liberarsi dal bisogno che inchioda.
IL BISOGNO COME LEVA TRASFORMATIVA:
LO SCIOPERO ALLA ROVESCIA
Nell’azione dolciana, il bisogno non è un limite, ma un punto di partenza. È il bisogno di acqua che motiva il primo sciopero alla rovescia del 1956 a Partinico, quando Dolci e un gruppo di disoccupati si mettono a lavorare spontaneamente su una strada pubblica senza autorizzazione, per dimostrare che il lavoro c’è, ma manca la volontà politica di riconoscerlo. La forza simbolica dello “sciopero alla rovescia” risiede nella sua capacità di trasformare un atto di disperazione in un gesto politico ed educativo. La paura del carcere o della repressione si scioglie nel riconoscimento reciproco tra i partecipanti, nel senso di comunità che si crea attorno a un obiettivo condiviso. Il bisogno, in Dolci, non è solo fame o mancanza: è domanda di giustizia. È energia vitale che, se riconosciuta, diventa azione. Il suo approccio parte dalla constatazione della realtà – pozzi secchi, scuole assenti, disoccupazione cronica – ma non si ferma alla denuncia. Ogni bisogno può diventare un progetto educativo, un’occasione per apprendere insieme e ricostruire. Dolci capovolge il paradigma dell’assistenzialismo: non dà risposte dall’alto, ma crea le condizioni perché le persone, anche le più umili, trovino dentro di sé la forza di interrogarsi, di proporre, di agire. La serenità di Danilo Dolci era una assicurazione contro la paura della Mafia, dello Stato, dei Tribunali…
IL SOGNO COME METODO EDUCATIVO
DELLA MAIEUTICA RECIPROCA
La parola “sogno”, in Dolci, non è evasione, ma metodo. Si esprime in modo emblematico nella maieutica reciproca, la pratica pedagogica fondata sul dialogo e sull’ascolto profondo. Ogni persona – bambino, adulto, anziano – è portatore di un sapere che va fatto emergere, non imposto dall’esterno. La maieutica non è solo una tecnica, ma un atteggiamento: si educa sognando insieme ciò che non c’è ancora. Nel Centro studi e iniziative per la piena occupazione di Partinico, Dolci costruisce uno spazio fisico e simbolico dove i giovani, i contadini, gli operai possono interrogarsi sui propri sogni. Le “interviste collettive” con i bambini delle borgate rurali diventano un laboratorio di immaginazione sociale: si parla del lavoro dei genitori, della mancanza di scuola, della fame, ma anche del desiderio di un mondo giusto, di un futuro diverso. Nel pensiero dolciano, sogno e bisogno si intrecciano nella costruzione di una coscienza collettiva capace di superare la paura. La paura è reale, ma può essere nominata, condivisa, elaborata. Non va negata, ma attraversata insieme agli altri. Un esempio chiave è il lavoro con i detenuti del carcere dell’Ucciardone a Palermo, dove Dolci conduce incontri basati sulla parola e sull’ascolto. Anche lì, la paura – della solitudine, dell’oblio, del giudizio – viene trasformata in possibilità educativa. Il bisogno di dignità si coniuga con il sogno di redenzione.
Allo stesso modo, i racconti contenuti in opere come Banditi a Partinico (Laterza 1957, ora Sellerio 2009) o Chi gioca solo (Einaudi 1966) restituiscono la voce di chi è solitamente escluso dalla narrazione pubblica: pastori, pescatori, braccianti, donne analfabete. Sono voci che sognano, perché vivono nel bisogno. E sono voci che, nel raccontarsi, rompono la paura. In Banditi a Partinico Dolci coniuga “banditi” in due modi: il primo per la presenza della mafia, il secondo perché a Partino era bandita la giustizia, il progresso, il lavoro…
Il sogno, per Dolci, è un elemento politico. Non è evasione, ma esercizio progettuale. Nei suoi laboratori educativi e nelle attività del Centro Studi di Partinico, il sogno si traduce in maieutica reciproca: un processo in cui ciascuno contribuisce con la propria esperienza e il proprio desiderio di futuro. È un’educazione che nasce dal basso, in cui si coltiva la capacità di immaginare alternative e di dare loro forma concreta. Il sogno è l’opposto della paura: dove la paura chiude, il sogno apre. Dove la paura isola, il sogno connette. Dove la paura divide, il sogno ricuce.
EDUCARE AL DESIDERIO E ALLA SPERANZA
Educare, allora, è “traghettare memoria”, restituire voce, risvegliare il sogno negli spazi in cui la paura sembra avere preso il sopravvento. E riconoscere che ogni sogno, se ben nutrito, può diventare progetto. Il lascito di Danilo Dolci non è solo pedagogico o sociopolitico, ma profondamente umano. In un’epoca di crisi della parola e di sospetto verso l’utopia, egli ci invita a ripartire dal bisogno e dal sogno come atti radicali di resistenza alla paura. Perché ciascuno cresce solo se sognato, e ogni comunità può rinascere solo se qualcuno la sogna con amore. Danilo Dolci non ha mai separato il sociale dal personale, il politico dall’intimo. Nel suo lavoro, sogno e bisogno sono due facce della stessa realtà: la spinta a non rassegnarsi, a dare senso alla propria esistenza e a quella degli altri. Di fronte alla paura che torna a farsi strada nei contesti fragili di oggi, il suo insegnamento resta vitale: solo chi sogna può cambiare, e solo chi parte dai bisogni può costruire un sogno che appartenga a tutti. In questo modo egli ha favorito l’esternazione del desiderio (sognato) per conquistare una vita personale nonché collettiva più vera, più vicina ai valori di uguaglianza e di solidarietà In un certo modo lo potrebbe definire un “apostolo del desiderio” parafrasando Philips Roth (Il professore di desiderio, Einaudi 2014).
Nel contrasto alla paura, Danilo Dolci ci ha insegnato che non basta denunciare l’ingiustizia: occorre educare alla speranza. Ma non una speranza passiva, bensì attiva, fondata sulla responsabilità individuale e collettiva. Il sogno, così, diventa progetto; il bisogno, diritto; la paura, consapevolezza e reazione.
“Ciascuno cresce solo se sognato,” è forse la sintesi più poetica e radicale del suo pensiero.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- Danilo Dolci, Banditi a Partinico, Torino, Einaudi, 1955.
- Danilo Dolci, Chi gioca solo, Torino, Einaudi, 1956.
- Danilo Dolci, Inchiesta a Palermo, Torino, Einaudi, 1958.
- Danilo Dolci, Spreco, Torino, Einaudi, 1960.
- Danilo Dolci, La struttura maieutica e l’evolverci, Firenze, Nuova Italia, 1996.
- Centro Studi Danilo Dolci, www.danilodolci.org
YouTube:
- Nova Lectio: Danilo Dolci: il Gandhi italiano che scosse la Sicilia. https://www.youtube.com/watch?v=vtRkj_o8Yi4
- Dio delle zecche.
https://www.youtube.com/watch?v=h5q-MZ0nWq8 - Danilo Dolci alla Olivetti di Ivrea.
https://www.youtube.com/watch?v=I141ApYK3X0 - Belice 50 anni dopo, l’SOS di Danilo Dolci: “Qui si compie un delitto di enorme gravità”.
https://www.youtube.com/watch?v=627Zauoe0ds